Il Gioco del Ponte di Pisa: storia e costume
Pubblicato il :
18/06/2018 15:39:23
Categorie :
Storia e tradizioni

LA STORIA DEL GIOCO DEL PONTE - LE SQUADRE DEL GIOCO DEL PONTE - IL GIOCO DEL PONTE OGGI
Il Gioco del Ponte è una manifestazione storica che si svolge nella città di Pisa, nel mese di giugno, chiamato il "Giugno Pisano". Si articola in due momenti distinti ma altrettanto significativi: il Corteo Storico sui Lungarni, una parata con oltre 700 figuranti in costume d'epoca, e la battaglia sul Ponte di Mezzo, dove le squadre dei quartieri appartenenti alle due Parti cittadine rivali, Tramontana a nord dell'Arno e Mezzogiorno a sud dello stesso fiume, danno prova della rispettiva potenza fisica, in un’evento agonisticamente avvincente.
Si ritiene che il Gioco abbia avuto origine dalla trasformazione locale del Gioco del Mazzascudo, che, dall’undicesimo al tredicesimo secolo veniva giocato come una battaglia simulata nell’antica Piazza degli Anziani, oggi Piazza dei Cavalieri, solitamente nel periodo di Carnevale ed aveva la funzione di addestrare gli uomini alla guerra.
In quest’arena i singoli giocatori (combattenti), equipaggiati con corazze, mazze e scudi, potevano misurarsi l'uno con l'altro per tutta la giornata. Gli scontri individuali lasciavano posto, nel finale, ad una battaglia generale con i combattenti suddivisi in due schiere "del Gallo" e "della Gazza".
“E' l'aprile del 1381 quando finalmente le due rive dell'Arno sono congiunte da un bel ponte di pietra per tendere il quale è stato spazzato via il vecchio passaggio in legno, angusto e ingombro di botteghine: nascerà cosi in seguito, su questo ponte, il vero e proprio Gioco del Ponte”
 La prima edizione del Gioco del Ponte conosciuta e certa porta la data del 22 febbraio 1568. Il Ponte, sede della Battaglia, era il Ponte Vecchio, corrispondente all’attuale Ponte di Mezzo, e scopo dello scontro era la conquista della parte avversaria. I giocatori di Tramontana e Mezzogiorno, erano suddivisi in squadre composte ciascuna da 50 o 60 soldati. Ogni squadra si distingueva per propri colori ed insegne
La prima edizione del Gioco del Ponte conosciuta e certa porta la data del 22 febbraio 1568. Il Ponte, sede della Battaglia, era il Ponte Vecchio, corrispondente all’attuale Ponte di Mezzo, e scopo dello scontro era la conquista della parte avversaria. I giocatori di Tramontana e Mezzogiorno, erano suddivisi in squadre composte ciascuna da 50 o 60 soldati. Ogni squadra si distingueva per propri colori ed insegne
Nel corso dei secoli il Gioco è stato più volte ripristinato e interrotto, subendo progressive modifiche alla formula originale. Il luogo della disputa venne trasferito sul Ponte di Mezzo e alle mazze e agli scudi fu sostituito il Targone, una tavola di legno coi colori delle Squadre cittadine, lungo oltre un metro e pesante più di due chili e mezzo, oblungo ed asimmetrico, con le estremità arrotondate, una larga e l’altra stretta. L'ultima Battaglia disputata con questo sistema risale al 6 febbraio 1807: c’e’ chi ne attribuisce la sospensione alla regina reggente d'Etruria, Maria Luisa, che resasi conto della cruenza della manifestazione pronunciò la celebre frase: "per Gioco è troppo, per guerra è poco", e chi invece la attribuisce al Granduca Leopoldo che vedeva nella battaglia un desiderio di autonomia della città di Pisa, un tempo gloriosa, prima della dominazione fiorentina.
Nel dopoguerra, per evitare lo scontro diretto, fu ideato un mezzo meccanico, un “carrello” scorrevole su rotaia, sul quale viene esercitata la spinta dei combattenti, la modalità con la quale il Gioco del Ponte si svolge attualmente.
LE SQUADRE DEL GIOCO DEL PONTE
L'Arno divide Pisa in due territori denominati parte di Mezzogiorno e parte di Tramontana. Infatti se noi volgiamo lo sguardo verso il mare, seguendo il naturale corso del fiume, abbiamo alla nostra destra il territorio a nord dell'Arno chiamato Tramontana, e alla nostra sinistra il territorio a sud del medesimo chiamato Mezzogiorno.
Le squadre che si affrontano nel Gioco del Ponte sono 12 e rappresentano i 12 quartieri della città, sono dette Magistrature; ecco tutti i colori ed i motti delle Magistrature del Gioco del Ponte:
|
Tramontana: Numquam retrorsum |
|
|
..vecchio e decrepito io sono, portami rispetto o ti bastono... |
.. m'arde d'onore la fiamma ... |
|
.. numquam retrorsum ... |
... alla giornata ... |
|
... vincere bisogna ... |
…melius dare qua accipere .. |
|
Mezzogiorno: Ultra Dimidium |
|
|
…senza temer tempesta ... |
... sum felix velix ... |
|
S. Marco |
... Pisa a pugnare invitta, a vincere nata... |
|
... virtus unita fortis ... |
... Pisa tremare fa l'acqua e la terra ... |
Sono nomi che vengono dal passato, da antiche compagnie militari pisane per l'appartenenza territoriale ad un quartiere, o di provenienza mitologica, come si desume dalle "imprese" disegnate sulla bandiera.
Il Gioco del Ponte (Giòo der Ponte in Pisano) è una festa storica che ogni anno si svolge sul Ponte di Mezzo a Pisa, l'ultimo sabato di giugno.
Il Gioco consiste, ai giorni nostri, nella spinta di un carrello (quello che è rappresentato sul pezzo del cavallo) lungo un binario appositamente montato sul Ponte di Mezzo; in questa sfida si affrontano le Magistrature, (ovvero i quartieri della città) riunite nelle Parti di Mezzogiorno e Tramontana Prima della Battaglia si svolge il corteo storico in costume: le vesti, in stile spagnolo cinquecentesco, sono sempre le stesse cucite per l'edizione del Gioco del 1935. Il corteo è composto da 709 figuranti, dei quali 41 a cavallo e percorre i Lungarni, le quattro strade che costeggiano il tratto centrale cittadino del fiume Arno.
L'assetto moderno del Gioco prevedeva, sino alla fine del secolo scorso, sei combattimenti tra le 12 Magistrature, più una eventuale sfida di spareggio, combattuta tra due squadre composte dai migliori combattenti delle Parti. Durante il corso degli anni il gioco ha subito varie modifiche al regolamento e, per favorirne lo sviluppo e la ripresa a partire dall'edizione 2007, viene gestito da una apposita Fondazione.
Dal 2010 si è tornati all'assetto di sei combattimenti con eventuale spareggio.

Indipendentemente dal numero delle Magistrature partecipanti, comunque, il combattimento si svolge con le stesse regole di base. Una volta schierati i combattenti ai due lati del "carrello" bloccato in posizione di partenza, ovvero centrale sul ponte, i Capitani li preparano per la partenza ordinando di esercitare la massima spinta possibile. Quando i capitani ritengono che la pressione esercitata sia adeguata, danno comune consenso al giudice di gara, il quale sgancia immediatamente il carrello che è dunque libero di muoversi lungo i binari. A questo punto, sta nella forza relativa delle due Squadre determinare la durata e l'intensità del combattimento stesso, che può durare da pochi secondi a decine di minuti: il record attuale è di 22 minuti e mezzo circa, stabilito nel 1992 nella sfida tra San Michele e Delfini, con vittoria dei primi, mentre quello di brevità risale al 1988 in cui i Delfini vinsero su Santa Maria in 11".
L'obiettivo del gioco è spingere il carrello verso la parte avversaria; il combattimento termina quando cade la bandierina di fine corsa, da un lato o dall'altro. Durante il combattimento, che oltre alla forza è determinato dall'astuzia e dall'esperienza dei Capitani e dei combattenti, si distinguono fasi di "pressione", in cui una squadra lentamente ma inesorabilmente aumenta appunto la forza con cui spinge, e fasi di "attacco", che generalmente si realizza quando una squadra, all'unisono, effettua un piegamento sulle gambe. L'attacco si dice che "entra" quando i combattenti della squadra che attacca riescono a distendersi sotto il tubo a seguito del piegamento, avendo dunque guadagnato preziosi centimetri.

La posizione della spinta, frutto di anni di esperienza e raggiunta per approssimazioni successive, si ottiene poggiando il collo e le spalle sui bracci del carrello, spingendo quindi all'indietro. Il regolamento prevede che si possano utilizzare alcuni dispositivi di protezione individuale:
- un cuscino, rigido o meno, di materiale vario, che viene posizionato tra le spalle del combattente ed il tubo del carrello;
- una cintura, generalmente di cuoio pesante, cui è attaccato un bastone che serve al combattente per poggiarvi le mani ed esercitare una spinta anche con le braccia;
- scarpe, generalmente modificate, con una sorta di tacco sulla punta in modo da mantenere il naturale angolo retto tra la caviglia e la gamba, altrimenti impossibile data la peculiare posizione di spinta.
Controversie esistono in merito all'uso di bustini, corpetti rigidi e quant'altro atto a tutelare la schiena nel momento della spinta. Il regolamento infatti ne vieta l'impiego.


 English
English Deutsch
Deutsch

 Satiri
Satiri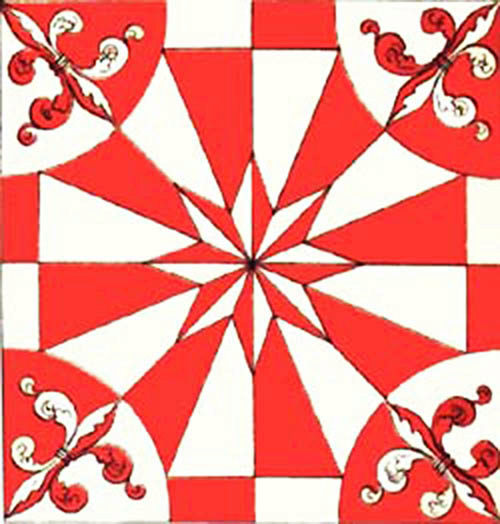 S. Francesco
S. Francesco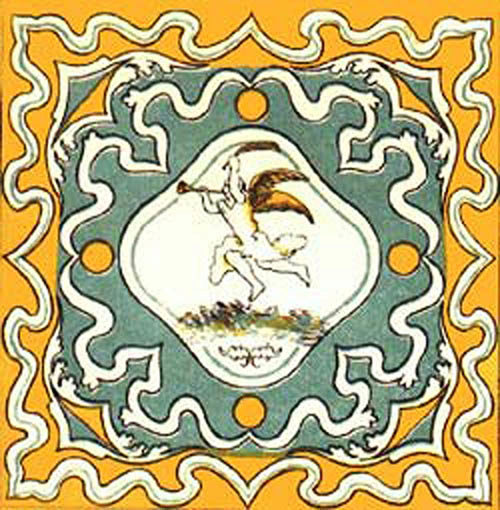 Calci
Calci S. Maria
S. Maria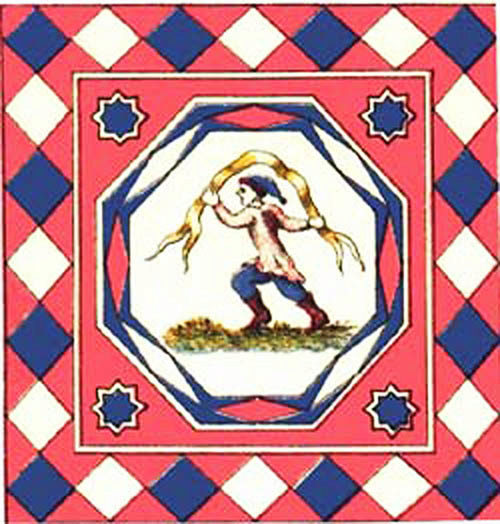 Mattaccini
Mattaccini S. Michele
S. Michele 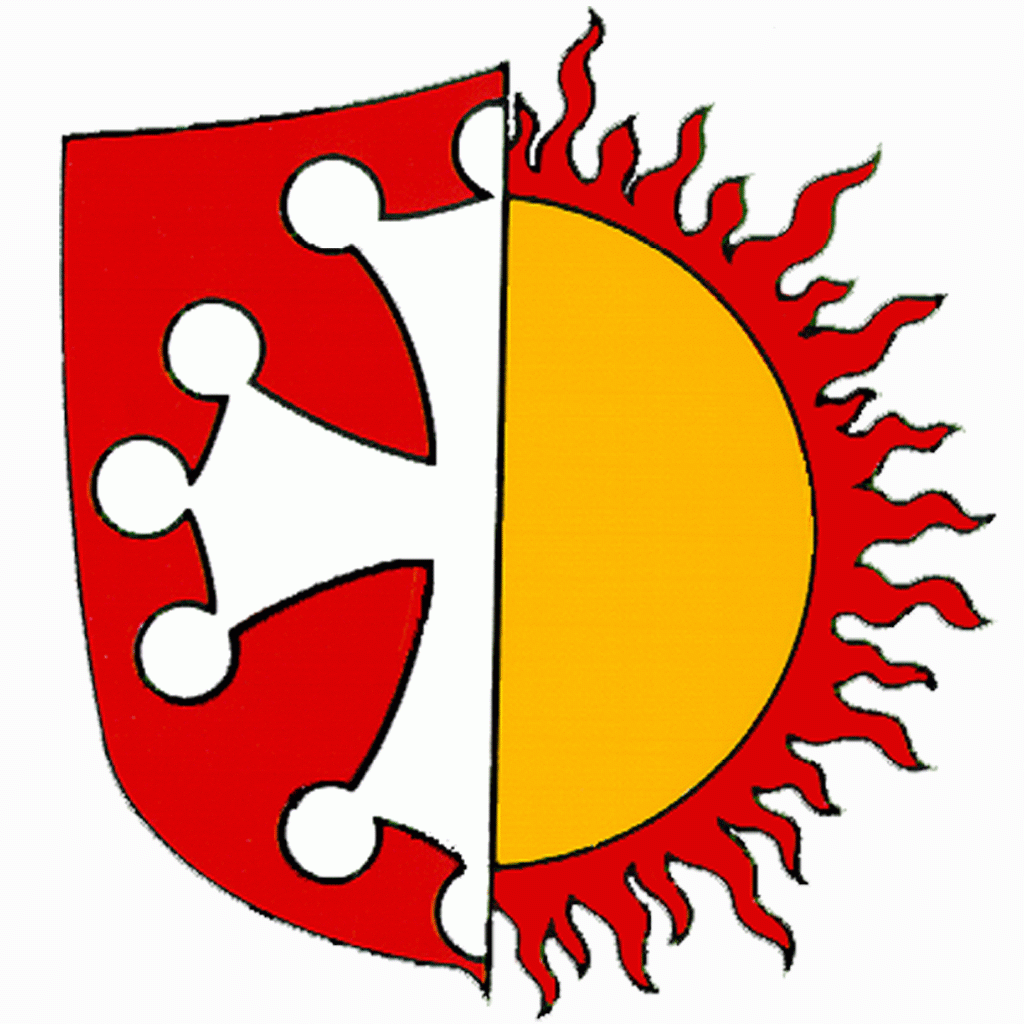
 Delfini
Delfini Dragoni
Dragoni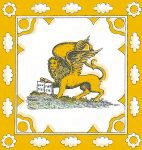 Magistratura di San Marco
Magistratura di San Marco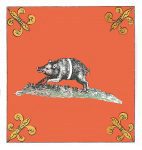 S. Antonio
S. Antonio Leoni
Leoni S. Martino
S. Martino
